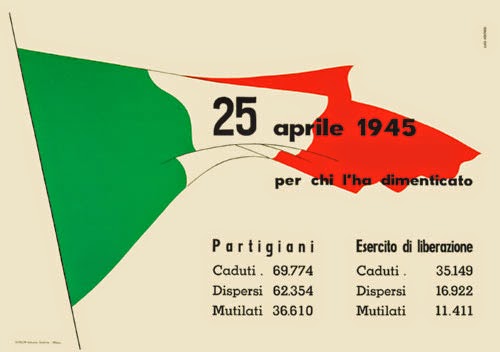Una fila di uomini che
si inerpicano sul punto più alto del tetto di quell’edificio dove li aspetta l’ultimo
elicottero. L’ultima via di fuga da agguantare con la forza della disperazione.
L’edificio è il numero 22 di Long Street, l’ambasciata americana di Saigon,
capitale del Vietnam del Sud. Il momento è il pomeriggio del 30 aprile 1975. Il
giorno che finì la guerra del Vietnam.
E’ una delle foto simbolo del
ventesimo secolo, perché ne coglie uno dei momenti più drammatici: la prima e a
tutt’oggi unica sconfitta americana in una guerra dichiarata, l’atto conclusivo
di una guerra che fu soprattutto un evento epocale, uno spartiacque per una
intera generazione non solo dal punto di vista storico-politico, ma anche e
soprattutto da quello della coscienza.
Saigon giai phong. Significa Saigon
è liberata, in lingua vietnamita. Oppure Saigon è caduta, dal punto di vista
degli sconfitti, di coloro che salivano su quegli elicotteri che facevano la
spola dal tetto dell’ultima ridotta americana in Vietnam, prima dell’arrivo ormai
imminente dell’Esercito del Popolo. Questa fu la notizia che quarant’anni fa
sorprese un mondo che sapeva da tempo quale sarebbe stato l’esito di quel
conflitto nel lontano sud-est asiatico che tutte le sere per anni era entrato nelle
case all’ora del telegiornale fino a diventare un compagno abituale, ma che non
se lo aspettava così presto, così repentino.
Da quando il leader comunista Ho
Chi Minh aveva sollevato il paese contro l’amministrazione coloniale francese
subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, il Vietnam era sempre stato
in guerra. I francesi erano stati finalmente sconfitti nel 1954 a Dien Bien Phu e il
trattato di Ginevra aveva posto fine al periodo coloniale. A quel punto il
paese si era diviso in due parti, il nord controllato dal Vietminh, l’esercito
di liberazione filocomunista di Ho Chi Minh e del leggendario generale Nguyen
Giap, ed il sud governato da Bao Dai – l’ultimo imperatore, messo sul trono dai
francesi – e dal suo primo ministro Ngo Dinh Diem.
Diem aveva deposto l’imperatore e
creato una repubblica che aveva cercato di resistere alla crescente influenza
comunista del regime del nord, supportato da Unione Sovietica e Cina. Fatalmente
la sopravvivenza del governo di Saigon era legata alla logica della Guerra Fredda
e dei suoi schieramenti. Diem chiese ed ottenne dagli Stati Uniti d’America un
sempre maggiore coinvolgimento nel Sud-Est asiatico, in quel momento la zona
più calda del mondo, la principale nella quale la Guerra fredda era diventata
guerra guerreggiata.
Al tempo dell’amministrazione
Kennedy, gli U.S.A. passarono da un sostegno più che altro logistico e
finanziario per il tramite dei cosiddetti consiglieri militari ad un
coinvolgimento diretto mediante l’invio di truppe. Nel 1963 a poca distanza furono
assassinati sia il presidente Diem che il presidente Kennedy. I loro successori
a quel punto si trovarono totalmente impelagati in una guerra senza quartiere
contro il regime di Hanoi.
Gli Stati Uniti pensavano di
ripetere una guerra come quella che avevano combattuto nel Pacifico dal ‘42 al ‘45
oppure in Corea dal ‘50 al ‘53. La previsione si rivelò ben presto infondata.
Il Vietnam si organizzò per combattere una vera e propria guerriglia
partigiana, al nord e soprattutto al sud dove i Vietcong, l’esercito di
liberazione popolare, dimostrarono ben presto di poter portare la guerra fino a
ridosso del quartier generale americano.
All’inizio del 1968, anno che
avrebbe segnato in tutto il mondo occidentale una svolta epocale ed uno
spartiacque delle coscienze, l’Offensiva del Tet (il capodanno vietnamita) condotta
dai Vietcong su vastissima scala contribuì a scuotere quelle coscienze
soprattutto negli U.S.A., fiaccando ulteriormente una voglia di combattere che
i ragazzi americani non sentivano già in partenza.
La sporca guerra, come fu
definita un po’ da tutta la società civile occidentale malgrado facesse parte
della logica dei blocchi contrapposti che aveva imperato fino a quel momento,
si trascinò fino al 1973. Finché l’amministrazione Nixon pose fine ad un
intervento militare statunitense ormai assolutamente impopolare e dai costi
spaventosi con gli accordi di pace di Parigi. L’impegno degli U.S.A. regredì al
livello iniziale del 1960. Gli ultimi consiglieri militari, soprattutto agenti
della C.I.A., lavorarono finché fu loro possibile per tenere in piedi il
governo del sud di Nguyen Van Thieu, ormai resosi odioso a tutta la popolazione
vietnamita per la sua corruzione e la sua brutalità.
I vietcong avevano già vinto in
prospettiva quando nel gennaio del 1975 dettero il via alla campagna di Ho Chi
Minh, l’attacco finale al sud intitolato alla memoria del leader comunista
scomparso nel 1969. Malgrado l’esercito americano avesse ormai lasciato quasi
completamente l’area, nessuno si aspettava una vittoria così fulminea delle
forze vietnamite, malgrado Giap e i suoi collaboratori avessero abituato il
mondo alla loro genialità tattico-strategica. Alla metà di aprile il destino
degli ultimi americani e dei loro alleati sudvietnamiti era segnato, restava da
conquistare solo la capitale e l’intero Delta del Mekong era in mano Vietcong.
Gli ultimi giorni del mese furono
impiegati dall’ambasciata americana per l’evacuazione del proprio personale,
che diventò frenetica, parossistica il 29, allorché l’aeroporto Tan Son Nhat fu
reso inservibile dai bombardamenti nordisti. A quel punto, l’unica via di fuga
dal Vietnam fu costituita dalla più ingente e clamorosa evacuazione per mezzo
di elicotteri della storia. L’operazione Frequent Wind portò via gli ultimi
americani dal tetto dell’ambasciata e consegnò alla storia del ventesimo secolo
e della Guerra Fredda una delle sue immagini più significative e suggestive.
Il 1° maggio, Saigon era già
stata ribattezzata Ho Chi Minh City, in onore del leader scomparso che aveva
ispirato trent’anni di guerre di indipendenza. Al Vietnam su cui sventolava la
bandiera rossa restava una delle più grandi vittorie di Davide contro Golia
della storia, a prescindere dalla connotazione politica che l’evento
inevitabilmente assunse in quel momento storico. Una vittoria di cui peraltro
fece subito pessimo uso proseguendo la guerra contro la vicina Cambogia, a quel
punto governata dal regime gemello dei Khmer Rossi di Pol Pot.
Al mondo intero rimase la
sensazione che un’epoca si fosse irrimediabilmente chiusa e che una nuova
società fosse alle porte. Nella mitologia post 68 la guerra del Vietnam occupa
un posto importante, nel bene e nel male. Speranze e delusioni degli anni
settanta e dei successivi passarono tutte per località dai nomi esotici del Delta
del Mekong e del Golfo del Tonchino. Ho Chi Minh finì per sostituire Fidel Castro, Che Guevara e Mao Tse Tung nell’iconografia comunista. La storia
americana e occidentale cambiarono per sempre, irrevocabilmente.
E soprattutto rimase – e rimane -
una immensa stele commemorativa nel Cimitero Nazionale di Artlington, in
Virginia. Il Vietnam Memorial riporta i nomi degli oltre 58.000 ragazzi
americani caduti o dispersi nel Sud Est asiatico nella più grande e sanguinosa
guerra guerreggiata dell’epoca del mondo diviso in due blocchi. Dell’oltre un
milione e mezzo tra soldati e civili vietnamiti caduti nello stesso periodo e nelle
stesse battaglie ovviamente non rimane nome e cognome. Soltanto la memoria collettiva.